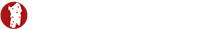L’idea è quella di creare una specie di factory nell’Isola in grado di riunire persone dai talenti diversi e innescare occasioni di confronto e di crescita. “Una non-accademia per portare qui in Sardegna il nostro know-how e metterlo in relazione con creativi e artigiani”, dice lo stilista algherese Antonio Marras (nella foto di Daniela Zedda). Uno step ulteriore di quello che è solito chiamare il suo “andare-restando”, ovvero un rapporto intenso con l’Isola che non è mai venuto meno anche quando è andato alla ricerca di nuove connessioni ed esperienze per alimentare il suo percorso, arricchirlo e contaminarlo. “Sono partito per scoprire cose nuove ma sempre mantenendo un fortissimo legame qui – dice -. Ora si tratta di fare in modo che non solo il concepimento dei nostri progetti ma anche la loro crescita parta dalla Sardegna”.
Marras viene da un periodo ricchissimo nel quale si è tenuto impegnato su più fronti. Anche durante la chiacchierata la mattina di Natale è seduto alla scrivania ad Alghero a lavorare ai suoi “pasticci”, mentre divaga di continuo parlando di moda, arte e design. “Io vado random, poi mi fermi”, ride lui. A settembre la maison ha presentato la collezione autunno/inverno, intitolata Arcipelaghi. Dietro c’è una storia a metà tra il fiabesco e l’onirico che è in linea con quell’idea di partire e tornare di cui Marras parla spesso. Racconta di due gemelle, le Cruccus, che una mattina si svegliano prese da una strana inquietudine, “Un tarlo che si insinua dentro e non ti lascia tregua e che ripete instancabilmente come un mantra: “Devi andare, devi andare, devi andare..” – si legge nella presentazione -. Andare, evadere, spostarsi, cambiare, scoprire nuovi mondi, nuovi orizzonti, nuove storie e vivere nuove emozioni”. Così partono per un viaggio e approdano in un’altra isola, dove conoscono una coppia di sorelle-principesse – le Kumas – con cui stringono subito un legame di amicizia, decidendo di proseguire il percorso insieme. La storia ha preso la forma di un video – realizzato in collaborazione con la fotografa Daniela Zedda, montaggio a cura di Roberto Ortu – che mette in scena questo viaggio, interpretato dalle modelle Alice ed Emanuela Cruccu e Kary e Balhi Khouma. Indossano abiti color verde salvia con stampe a fiori, camice bianche con l’iconico ritratto stilizzato realizzato a mano dall’artista, e ancora giacche militari rattoppate e ricamate. Tutto il multiforme universo poetico ed estetico di Marras, che troviamo anche in un altro progetto recente: le ceramiche, 300 pezzi unici realizzati dai fratelli Colì in Puglia e incisi a mano da lui con una straordinaria varietà di forme e decorazioni.
Arcipelaghi – Antonio Marras S|S 21 from Antonio Marras on Vimeo.
Partiamo dalle ceramiche. La sua passione nasce grazie al rapporto con Maria Lai e trova uno sbocco nella collaborazione con degli artigiani di Lecce. Come è nato il progetto?
Da anni avevo un debito con Maria. Voleva insegnarmi a lavorare la ceramica: avevamo già scelto insieme il forno e il punto della casa algherese dove sistemarlo. C’era un progetto che purtroppo non si è mai potuto realizzare. Da allora è passato un po’ di tempo. Devo dire che sono fato e caso a decidere per me. Non sono uno che programma o che intuisce quello che gli può servire: non è nelle mie corde. È successo durante un Salone del mobile. Ho conosciuto degli architetti pugliesi che poi sono andato a trovare nella loro terra. Lì ho scoperto l’azienda dei fratelli Colì: uno dei titolari è un ragazzo di 40 anni, straordinario. Con lui si è instaurato un rapporto di fiducia cieca, folle. Io sono ignorante in materia quindi non mi metto limiti nella struttura: disegno cose assurde e lui riesce a realizzarle.
Ormai sembra un amore che occupa uno spazio molto rilevante nella sua vita.
La ceramica è la mia terapia. Non una vera cura ma una malattia, in realtà. Il mio ferragosto l’ho passato in azienda a fare cose impossibili, isolato per una settimana: quello con la ceramica è un lavoro fisico molto duro, che ti dà moltissima adrenalina. Non mi stancherei mai di mettere le mani nella ceramica, di imbrattarmi, tastare, sperimentare nuovi elementi e nuove proporzioni.
Da un po’ di tempo ha in testa l’idea di radicare maggiormente il suo lavoro in Sardegna. Ce ne può parlare?
Ho sempre avuto la necessità, voglia, urgenza di andare, di viaggiare e scoprire quello che c’è altrove, di andare al di là di questo mare, che per me non è limite ma strada da percorrere per trovare altri approdi, altre realtà culture popolazioni, altri modi di vedere la vita, di scontrarsi e confrontarsi: un bisogno che abbiamo noi isolani di spostarci e dialogare con culture distanti. Però ho sempre combattuto per rimanere nell’Isola: ho costruito qui la mia sede, la casa laboratorio, la fucina dove nascono le mie idee, i miei stracci. Con la testardaggine di un sardo marino volevo che tutto accadesse qui. Poi lo esportavo e lo esponevo al mondo, ma l’amplesso veniva consumato in casa.
Foto di Daniela Zedda
Cosa aggiunge quindi l’idea della factory rispetto all’approccio che ha sempre seguito?
Mai come in questo momento, dopo un lockdown che ha segnato un cambiamento profondo nel nostro lavoro ma anche nelle nostre vite, nella concezione stessa dell’esistenza, ho pensato che fosse il momento di provare a fare una cosa. Far sì che non solo il concepimento ma anche la crescita delle cose venga fatta qui. Che non vuol dire perdere contatti, occasioni e incontri che vengono fatti fuori, a Milano, Parigi, New York. Quello che abbiamo pensato è di portare in Sardegna tutte le nostre competenze e metterle in relazione col territorio. Faccio un esempio: io faccio abiti, tra le altre cose, e ci sono aziende che potrebbero seguire la produzione qui. Ma non solo. Vorrei fare una sorta di non-accademia, un luogo dove si possano incontrare e confrontare talenti di varia estrazione e artigiani in modo da produrre oggetti d’arte.
Avete pensato anche a iniziative legate alla moda?
Io e mia moglie Patrizia abbiamo un archivio di diecimila pezzi e capi: quelli delle mie collezioni, quelli del mio lavoro di otto anni da Kenzo, ma anche pezzi acquistati da altri stilisti e designer. Siccome non mi drogo spendo i soldi comprando abiti. Abbiamo una vera e propria perversione e così l’archivio si è arricchito di capi più o meno importanti. Mi piacerebbe metterli a disposizione di ragazze e ragazzi, di scuole, fare mostre a tema o allestire una collezione permanente da far ruotare a seconda del percorso individuato, invitando anche i tantissimi personaggi che abbiamo conosciuto in anni di lavoro in questo campo e che impazzirebbero davanti alla possibilità di poter venire nell’Isola. Voglio creare cortocircuiti, scosse, attriti. Se credo in una cosa smuovo anche le montagne. Poi magari mi perdo in un bicchiere d’acqua, ma questa è un’altra storia.
Negli ultimi anni sembra che la moda sia diventata uno dei tanti ambiti con cui portare avanti il suo stile e il suo punto di vista: ha lavorato anche con teatro, design, allestimenti, arte contemporanea…
Ho sempre detto che sono uno prestato agli stracci. In realtà ci sono nato in mezzo: sono cresciuto nel negozio di mio padre ad Alghero. Ho iniziato a fare il bottegaio e non avevo velleità artistiche, tantomeno da stilista: era proprio l’ultima cosa al mondo alla quale pensavo. Un giorno un mio fornitore mi chiese di disegnare una collezione e pensai che fosse pazzo. Ho accettato dopo due anni e anche grazie a Patrizia nacque la prima collezione. Ma ero inesperto: non sapevo cosa fosse un giro manica, dove prendere i tessuti… Avevo una passione folle per il cinema e mi sarei voluto dedicare a quello: studiare regia, provare a fare lo scenografo. In generale ho sempre coltivato altre cose rispetto alla moda: danza, teatro, ho pasticciato cose e poi grazie a Maria Lai – dopo anni – sono riuscito a far uscire le mie opere dai cassetti. Insomma, continuo in fondo a fare quello che ho sempre fatto.
Anche la nuova collezione è “tenuta insieme” da una storia, un racconto che poi si traduce nei singoli capi.
Abbiamo sempre raccontato storie. Come nella prima collezione per cui avevo attinto dal guardaroba di mio zio, un uomo molto elegante che usava giacche meravigliose e che io avevo modificato e rimontato su manichini da donna. In quell’occasione raccontavo il viaggio di alcune donne sarde che partivano con un piroscafo: durante il tragitto si verificava un cambiamento. Faceva freddo e si coprivano con gli abiti dei loro uomini, li adattavano alle loro esigenze e li abbellivano. Poi c’era il confronto-scontro con la cultura argentina, quella del tango, della sensualità, dei sentimenti rivelati ed esposti a differenza di quelli sardi più interiorizzati, privati. Infine c’è una liberazione. Ho raccontato anche Eleonora D’Arborea, la mamma di Italo Calvino, Frida Kahlo in tempi non sospetti. Ogni collezione e ogni sfilata hanno una storia. Soprattutto la sfilata rappresenta il momento topico di un lavoro che dura sei mesi, che si svolge in pochi minuti e non ammette possibilità di replica. In quei dieci minuti devi dare tutto e convincere le signore in prima fila, fare in modo che dentro di loro rimanga un frammento, un frame di quello che abbiamo proposto. Ecco perché sono un rompiscatole per le sfilate: mi preoccupo di ogni dettaglio, ho bisogno di sapere che tutto andrà nella maniera migliore.
La pandemia ha prodotto una serie di riflessioni sul modo in cui la moda cambierà nel prossimo futuro – e in realtà sta già cambiando. Come è stata la sua esperienza?
Tutto è cambiato. E in maniera drastica. Partiamo col dire che io non vendo t-shirt o felpe. Ogni capo necessita una lavorazione con almeno venti passaggi: assemblaggio, ricamo, rifinitura… Elementi e oggetti che devi vedere e toccare. Il lavoro a distanza complica alcuni passaggi. Ho sempre pensato che il rapporto umano sia fondamentale e tale debba rimanere. Non compro nulla via internet: sono preistorico, nuragico. Se non tocco con mano perdo l’interesse nell’oggetto. Invece ora più che mai il web è fondamentale. Ora i clienti non possono arrivare nel nostro atelier e quindi dobbiamo lavorare online. Arriva un ordine, dobbiamo far vedere le foto, mostrare via video le modelle che indossano i capi, come calza la scarpa e così via. Prima era normale venire a trovarci in atelier, toccare i tessuti. E la cliente poteva provare i capi. Il percorso online ora dura qualche ora in più. Questo è uno dei cambiamenti. Bisogna farsene una ragione e capire come mettere in atto una rivoluzione.
Il virus si è portato via lo stilista Kenzo, con cui ha lavorato tanti anni. Un suo ricordo?
La sua prima collezione la realizzò una signora italiana, Deanna Ferretti, una mia carissima amica e amica intima anche di Kenzo. Quando la figlia Sonia si è sposata siamo andati al suo matrimonio. L’ho conosciuto in quell’occasione, alla festa di nozze che è andata avanti fino alle cinque del mattino. A un certo punto ci siamo buttati tutti in piscina e ho ancora il ricordo di Kenzo in acqua in mutande. Era una persona solare, gentile, educata. Il più occidentale dei giapponesi: ha coniugato oriente e occidente, Parigi con Tokyo, ha fatto che il colore fosse predominante laddove i suoi conterranei erano minimalisti e neri. Ha mischiato, miscelato, contaminato col suo modo di essere. E ha segnato pagine epocali della storia della moda.
Andrea Tramonte
LEGGI ANCHE: Antonio Marras in mostra con la ‘jana’: “Il mio legame speciale con Maria Lai”