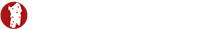Carola Farci, cagliaritana 28enne, è partita sabato per un progetto di volontariato con il popolo Sahrawi, che da quarant’anni vive esule nel deserto dell’Algeria a causa di contrasti con il Marocco. La giovane, insieme al gruppo dell’associazione Looking4, dopo un lungo viaggio in aereo da Cagliari verso Tindouf ha raggiunto in campo di Auserd, nel mezzo di un deserto arido e inospitale. L’ultima parte del percorso il gruppo è stato scortato dall’esercito algerino e poi da quello della RASD, Repubblica Araba Saharawi Democratica. Dopo le prime puntate del diario (qui il viaggio e l’arrivo, qui il secondo e terzo giorno nel deserto, qui il quarto) ecco in esclusiva per SardiniaPost il nuovo racconto.
Quinto giorno. Sesto, se contiamo anche il viaggio. I nostri capelli stanno cominciando a prendere vita.
Ieri qualcuno avrà notato che non è uscita la cronaca quotidiana. È colpa dei problemi legati alla connessione e alla durata delle giornate: qui l’avventura sta per finire e 24 ore al giorno non bastano più per fare tutto ciò che vorremmo. Così la mattina ci dividiamo e, mentre Marco continua il suo percorso di psicomotricità funzionale per i bambini che ne hanno bisogno, noi intraprendiamo altre attività, alcune all’interno del campo, altre fuori. In particolare tra ieri e oggi abbiamo cercato di capirne di più della Storia di questo popolo. Se studiare la Storia è sempre importantissimo, in questo caso si rivela davvero fondamentale.
I Saharawi si trovano in questo deserto inospitale perché esiliati dalla loro terra, il Sahara Occidentale, una zona a ridosso dell’Oceano Atlantico dove vivevano prevalentemente di pesca. Dopo l’irruzione dell’esercito marocchino sono però dovuti fuggire, senza poter portar nulla con sé, con l’unico obiettivo di aver salva la vita. E l’unico posto dove si son potuti fermare, finalmente salvi, è questo deserto inospitale dove ci troviamo ora, nell’Algeria meridionale.
Tutto ciò è successo nel 1975. Da allora i Saharawi attendono giustizia, aspettano di ri-impossessarsi della propria terra. E, sino al 1991, hanno ingaggiato una guerra contro il Marocco, riuscendo a recuperare, poco a poco, qualche territorio, i cosiddetti “territori liberati”. Oltre i quali i marocchini hanno eretto un muro che non permette loro di avanzare ulteriormente. È importante capire questo, averlo ben chiaro: il problema che affligge i Saharawi è, prima di tutto, politico. Tutto il resto, il luogo inospitale, le condizioni di vita difficili, la dipendenza dagli aiuti umanitari, sono una conseguenza di questo problema politico.
Per questo ieri mattina abbiamo deciso di andare al museo della guerra e all’Ufficio di coordinamento saharawi per le mine. Le poche centinaia di chilometri che dividono i campi in cui ci troviamo dallo Stato del Marocco sono infatti piene zeppe di mine antiuomo, alcune delle quali sono state bonificate, altre solo individuate, mentre di moltissime altre non si sa se ci siano e dove siano. Sono disseminate qua e là, e di tanto in tanto si fanno ancora sentire col loro carico di morte. Mine che, spesso, portano l’etichetta “made in Italy”.
Vederle segnalate nella mappa, saperle attorno a noi, ci riempie di inquietudine. Ma ci inquieta ancora maggiormente parlare con chi gestisce la rimozione, ci racconta di un lavoro in cui si cimentano sia uomini che donne, un lavoro che non si sa quando potrà terminare. Vedere le foto dei Saharawi nella loro terra di un tempo, occupati in attività quotidiane, e le immagini della guerra che ritraggono gente proprio come noi, con le All Stars ai piedi e i pantaloncini, fa invece uno strano effetto.
Usciamo da lì con la sensazione di un’ingiustizia irreparabile, sempre domandandoci cosa possiamo fare noi per dare una mano a questo popolo che, dopo quarantatré anni, ha ancora la voglia e la dignità di lottare per la sua causa.
Quando torniamo ad Auserd, nel pomeriggio, continuiamo il sostegno alle famiglie: di casa in casa, di tenda in tenda, portiamo il materiale e le donazioni raccolte in Italia. Ci troviamo in degli stanzoni senza assolutamente nulla, solo un cumulo di coperte e il braciere per il tè, noi che siamo abituati all’arredamento, all’oggettistica, quasi all’horror vacui domestico.
E fu sera e fu mattina. Sesto giorno.
Stamane la sveglia è all’alba per andare a vedere il famoso muro, questa barriera infame che divide i “territori liberati” – e le rispettive mine antiuomo – dal Marocco. Ci rechiamo là con la jeep messaci a disposizione dalla RASD, e la relativa scorta. I “territori liberati” sono una sorta di “no man’s land”: non più Algeria, non ancora Marocco, non ufficialmente Repubblica Saharawi. Percorriamo dunque circa due ore di tragitto, in una strada non adatta ai deboli di cuore o di coccige. Fuori dal finestrino l’immagine è una sequenza fissa: una piana desertica, senza nulla. Ovunque il giallo del suolo e il celeste del cielo. Nient’altro. Poi, improvvisamente, la jeep della scorta dietro di noi ci fa le luci. Poi comincia a suonare il clacson. Poi ci supera e ci taglia la strada, per cui siamo costretti a fermarci.
Che succede?
Siamo usciti dal tragitto tracciato e stiamo rischiando di saltare in aria a causa delle mine? La scorta è in realtà un gruppo terroristico e ci vuole sequestrare? Oppure è il nostro autista ad essere un pericoloso criminale che sta cercando di rapirci?
Niente di tutto ciò: la scorta ci segnala che a poche centinaia di metri da là c’è un piccolo accampamento nomade e che ci si può fermare per fare merenda col pane cotto sulla brace e del latte di capra appena munto. E il tè.
Così facciamo.
Quando poi risaliamo a bordo del fuoristrada manca ormai poco per la nostra destinazione finale. Eccolo, finalmente lo vediamo: il “muro”. Che è, a tutti gli effetti, un muro. Un muro di sabbia, con davanti del filo spinato e dietro le vedette marocchine che ci osservano. Avvicinarsi troppo non è possibile, anche perché dei cerchi in terra ci suggeriscono la posizione di alcune mine. Lo osserviamo da lì, ci domandiamo il perché di questo muro e di tutti i muri, di tutte quelle barriere inutili che marcano un “noi” e “loro”.
Nella strada del ritorno, la scorta e il nostro autista si mettono d’accordo per una nuova sosta. Stavolta in una capannina in mezzo al nulla, dove ci fermiamo per un tè e un’arrostita di fegato e gobba di dromedario. Che noi, per prudenza ma a malincuore, rifiutiamo.
Il pomeriggio scopriamo le dune. Quando si pensa al deserto, tutti pensano all’immagine esotica delle immense dune di sabbia, morbide, dorate. Il deserto in cui si trova Auserd non assomiglia per nulla a quest’idea. È, al contrario, una piana con sabbia e roccia, che rievoca più la polvere che la duna. Però la buona notizia è che qualche chilometro fuori dalla città, qualche duna effettivamente c’è. Ci siamo andati insieme alla famiglia che ci ospita e a un mucchio di bambini che si sono divertiti a rotolarsi su e giù. Inutile dire che abbiamo approfittato per fare un tè. Altrettanto inutile dire che eravamo scortati dalla RASD: negli ultimi anni hanno attivato un protocollo molto rigido nei confronti degli stranieri, che non possono uscire dai campi senza scorta, non possono rientrare oltre le 19 ed entro le 22 devono essere in casa. E la RASD è molto ligia, per cui ogni sera telefona per sapere se siamo rincasati. Un interesse che da un lato complica un po’ le organizzazioni quotidiane, e a cui, effettivamente, non siamo abituati; dall’altro ci fa sentire continuamente protetti e al sicuro.
Anche oggi, dunque, rientriamo in tempo per il coprifuoco. E poi andiamo a comprare la pizza da dividere con la famiglia. La pizza? Sì, la pizza. Non per un momento di nostalgia dalla patria, ma perché qua, in questo piccolissimo angolo sperduto di mondo, una ragazza saharawi, qualche anno fa, ha aperto una piccolissima pizzeria. Looking4 le ha dato una mano e lei è riuscita a mettere su un piccolissimo forno in cui cuocere una pizza per volta, con tempi biblici e pochissima scelta. Ma, in pochi anni, si è ampliata, e adesso ha un forno vero e due dipendenti. Così siamo passati a portarle un piccolo aiuto per continuare l’attività e abbiamo preso la palla al balzo per assaggiare il risultato del suo lavoro: cosa dire? Non male per essere una pizza in mezzo al deserto!
E adesso che vi scrivo siamo qua, tutti in cerchio, nella tenda, insieme alla famiglia e gli infiniti cugini, zii, nipoti, vicini. Parliamo tutti lingue diverse e in genere non ci capiamo. Però guardiamo tutti assieme le foto di questi giorni, ridiamo e sorridiamo, ci guardiamo negli occhi e stiamo in silenzio. Nessuno si sente in imbarazzo durante i lunghi momenti in cui non si parla. Come dicevo il primo giorno, qui si condivide la presenza della persona. Non è necessario fare qualcosa assieme. Basta esserci.
E io, che dal mio angolino, sdraiata sul tappeto, osservo e scrivo, mi chiedo quando ci ricapiterà di trovare questo calore, quest’unione nella diversità, la bellezza disperata di questo popolo coraggioso.
Tra ventiquattro ore si parte, quella di domani sarà l’ultima cronaca. Mi godo l’ultimo tè della buonanotte. E la auguro anche a voi che continuate a seguirci. Grazie di cuore.
Carola Farci