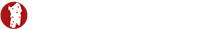Duecento casi. Duecento contagi di Covid-19 negli ospedali dell’Isola, tra medici, infermieri e oss. Un primato che farebbe vergognare qualunque azienda sanitaria. Ma le Assl sarde sono mute. Questa pagina nera di un’epidemia che già di suo fa paura, è al momento solo materia giudiziaria. Ad appannaggio di Procure che stanno aprendo fascicoli su fascicoli, per fare chiarezza, dopo che sindacati e avvocati hanno raccolto e rilanciato la protesta montata in corsia. Contestazioni tenute volutamente sottotraccia, vista la minaccia della Regione di licenziare quanti avessero parlato. Senza considerare che proprio sui numeri si è registrato l’altro pietoso spettacolo. La Giunta, per il tramite dell’assessore alla Salute, Mario Nieddu, ha prima ha diffuso alcuni dati, poi li ha corretti al ribasso. L’unica bussola per orientarsi è il bolletino sanitario dell’Istituto superiore di sanità, quell’Iss che sta passando le settaccio i numeri dei contagi in tutta Italia. Stabilendo che in Sardegna, quando gli infetti erano ancora 490 (oggi sono 794), il personale sanitario colpito dal coronavirus valeva il 40,81 per cento del totale. Duecento casi, appunto, contro i 144 di cui ha parlato Nieddu. Sardina Post ha chiesto all’avvocato Giacomo Doglio – esperto di diritto sanitario, uno dei legali che sta seguendo l’epidemia negli ospedali – di spiegare, norme alla mano, l’effetto domino in corsia.
Avvocato, a metà marzo, quando la protesta silenziosa del personale sanitario è venuta fuori, si è capito che negli ospedali sardi mancavano i dispositivi di protezione individuale (Dpi). Si spiegano così quei duecento infetti che, percentualmente, valgono cinque volte la media nazionale?
È forte il sospetto che l’alto numero di sanitari positivi sia determinato dall’insufficiente adozione di misure di prevenzione e protezione. Indubbiamente, l’elevata contagiosità del virus, in un contesto emergenziale sottovalutato inizialmente e colpevolmente, ha reso la vita difficile. Ma ritengo che se si fosse investito per tempo sulla sicurezza, se si fossero adottati con la necessaria tempestività gli interventi organizzativi, informativi e formativi, nonché le prescrizioni di sorveglianza sanitaria, si sarebbe evitato il disastro che è sotto gli occhi di tutti. L’insufficiente dotazione dei Dpi, peraltro assolutamente ingiustificata, non può costituire una valida scusante per nessuno. Va sottolineato che il dato sardo dei contagi tra il personale sanitario è eclatante, ma non è certo da sottovalutare la percentuale nazionale.
In materia di Dpi qual è la normativa di riferimento?
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il decreto legislativo 81/2008, modificato e integrato nel tempo dalla normativa comunitaria. Il Testo unico stabilisce l’obbligo di adottare precise misure di protezione individuale da declinare in relazione al grado di rischio a cui un lavoratore è esposto. E si badi bene: quando il rischio riguarda un bene di rilevanza primaria, qual è la salute, l’assenza di certezza scientifica, che nell’attuale contingenza investe pure le modalità di trasmissione del virus, non può in alcun modo costituire una giustificazione per la mancata o la tardiva adozione di misure adeguate al contenimento della situazione di pericolo.
È certamente presto per dire se le Aziende sanitarie abbiano commesso violazioni di legge. Ma conferma che la delibera 13-24 della Regione è un’applicazione al ribasso le indicazioni sulla sicurezza fissate dall’Istituto superiore di sanità?
La conferma si ricava dal confronto tra le disposizioni regionali e quelle dell’Iss, a mio parere insufficienti, anche nella recente versione aggiornata. Di certo, nessuna adeguata tutela può essere assicurata al personale sanitario senza applicare il principio di precauzione. Nella fattispecie, i Dpi, in concorso con le altre misure non solo di prevenzione ma anche organizzative e di sorveglianza sanitaria, sono finalizzati ad assicurare la protezione del lavoratore contro qualunque rischio suscettibile di minacciare la sua salute quando è in servizio. Da qui, l’obbligo di innalzare le stesse misure di protezione individuale quanto più aumenta l’esposizione al rischio, tanto più nell’attuale situazione di incertezza scientifica.
Era un principio così difficile da capire?
No. E di sicuro un preciso dovere sarebbe stato quello di agire, a tutti i livelli, con la massima tempestività, avendo come stella polare la tutela della salute e sicurezza del personale sanitario. Riporre la massima attenzione sulle misure di prevenzione e protezione serve proprio a esercitare un controllo, il più possibile rigoroso, sul rischio di trasmissione, evitando che, paradossalmente, l’ospedale possa trasformarsi, come è stato purtroppo in diverse casi, in un focolaio d’infezione. Basti considerare che nel Piano pandemico nazionale, mai aggiornato da oltre dieci anni a questa parte nonostante le raccomandazioni del’Organizzazione mondiale della sanità, è espressamente previsto che l’approvvigionamento dei Dpi rientri tra le primissime misure di sanità pubblica da adottare. Addirittura nella fase interpandemica, ossia in quella di partenza, quando nemmeno esiste una situazione di allerta. Invece negli ospedali e nel territorio i Dpi non c’erano, e non si poteva certo pretendere che in piena emergenza si riuscisse a reperirli nelle quantità necessarie. Per questa ragione, e non per altro, coi decreti legge del 2 e del 17 marzo, rispettivamente il numero 9 e il 19, le mascherine chirurgiche sono improvvisamente diventate dispositivi di protezione individuale, con buona pace delle esigenze di sicurezza.
Alla fine una ricostruzione abbastanza facile: più Dpi e meno contagi.
Si, ma non solo. Un’altra variabile sulla quale vale la pena soffermarsi è la mancata esecuzione sistematica dei tamponi al personale sanitario. Si tratta di una misura di sorveglianza che andrebbe applicata a tappeto in tutti i luoghi dove si eroga assistenza medica o almeno quando si riscontrano casi di sospetta o accertata positività. Ho contezza del fatto, perché la circostanza mi è stata ripetutamente segnalata, che i test non sempre sono stati eseguiti con la necessaria tempestività. Talvolta nemmeno nelle situazioni più critiche con le conseguenze sui possibili contagi facilmente immaginabili, visto che l’operatore in attesa del tampone torna a casa e se è asintomatico anche al lavoro.
È pur vero, in assenza della tracciabilità degli spostamenti individuali, che non è possibile ricostruire per tutti i pazienti la catena di trasmissione dell’infezione.
Certo. Ma proprio questo avrebbe dovuto suggerire di considerare qualsiasi paziente che accede in un luogo di cura, o a cui viene prestata assistenza domiciliare, come sospetto di infezione, anche se asintomatico, con la conseguente adozione di tutte le misure necessarie.
La battaglia giudiziaria dei prossimi mesi, una volta passata l’emergenza, si giocherà tutta sulle mascherine che mancano negli ospedali?
I lavoratori, e ovviamente parlo della mia esperienza di queste settimane, vissuta a metà tra il ruolo dell’avvocato e quello del cittadino indignato, non stanno pensando a battaglie giudiziarie ma auspicano che sia assicurata la tutela della loro sicurezza e e della loro salute. Lavorare con serenità in un contesto con scarse tutele è difficile, ma diventa addirittura una lotta impari se non si dispone della necessaria protezione nel corso di una pandemia. Negli scorsi giorni, da un lato, si raccontava della disponibilità di mascherine chirurgiche, dall’altro, e non solo in Sardegna per la verità, ad alcuni lavoratori venivano distribuite le cosiddette swiffer. Contemporaneamente, però, abbiamo visto qualche rappresentante delle istituzioni con indosso i Dpi, nella fattispecie filtranti facciali, di cui evidentemente sconoscevano – fatto gravissimo – l’uso. Peraltro, tutti parlano genericamente di mascherine chirurgiche senza considerare che ve ne sono di diversi tipi: le più efficaci sono quelle di tipologia II R, dove la lettera ‘R’ garantisce la protezione dagli spruzzi. Ma è necessario anche l’utilizzo di occhiali di protezione o mascherine con visiera, così come di guanti e di camici idrorepellenti. In ogni caso, lascio immaginare quanti lavoratori, che non posso utilizzare i Dpi, abbiano a disposizione le mascherine più protettive.
Effettivamente il messaggio che passa, anche per la poca chiarezza della politica, è la sostanziale equiparazione tra Dpi e mascherine.
Invece esiste una sostanziale differenza, che è stata azzerata due volte: dalla modailità di gestione dell’attuale emergenza e da un intervento normativo di equiparazione. In estrema sintesi, i filtranti facciali, che come detto rientrano tra i Dpi, possono essere di diversa tipologia: Ffpi, Ffp2 e Ffp3, secondo l’ordine crescente di protezione, e hanno come finalità la protezione del lavoratore. Al contrario, le mascherine chirurgiche, sebbene conformi alla norma Uni En 14683 e ugualmente differenti per modello, sono dispositivi medici e hanno come scopo principale quello di proteggere il paziente dalla possibile contaminazione proveniente dall’operatore che le indossa. Oltretutto non hanno la stessa vestibilità né l’aderenza dei filtranti facciali e non svolgono alcuna funzione di protettiva batterica se sono contaminate, umide o danneggiate. Né risultano efficienti se utilizzate in modo prolungato, dal momento che sono monouso. Le mascherine, peraltro, non garantirebbero un’adeguata protezione, se venisse dimostrato, e gli studi scientifici non lo escludono, che la trasmissione del virus possa avvenire non solo tramite droplets, ossia le goccioline, ma anche per via aerogena, quindi attraverso particelle di dimensioni inferiori. Questo per dire che i filtranti facciali, in concorso con gli altri presidi di cui ho detto, assicurano la migliore protezione. Eppure sino a ieri non erano prescritti né dall’Istituto superiore di sanità né dalla Regione Sardegna nemmeno per quanti prestano assistenza diretta ai pazienti ricoverati in stanza Covid-19. Meglio non aggiungere altro.
Lei nei giorni scorsi ha scritto che un grave errore nella gestione dell’emergenza è stato il non considerare ogni paziente come un infetto potenziale. Un simile approccio avrebbe ridotto il numero di contagi tra il personale ospedaliero?
Ne sono convinto perché questa è anche la convinzione di chi lavora sul campo e ho grande fiducia nella percezione di chi, quotidianamente negli ospedali, nel territorio e nel domicilio dei pazienti, ha individuato tale criticità. Un approccio di questo tipo avrebbe favorito, e favorirebbe tuttora, una maggiore precauzione nella scelta delle misure organizzative e di protezione da adottare. Del resto, anche la contaminazione di quegli ospedali che pure erano stati individuati come Covid free, ovvero senza posti letto dedicati alla cura del coronavirus, sta a dimostrare che la visione ottimistica di partenza debba essere rivista. E questo invece è successo in parte, solo in parte.
Prevede orde di ricorsi da parte di medici, infermieri, tecnici e oss?
In queste settimane ho consigliato ai lavoratori di segnalare tutte le situazioni di rischio emerse. Dalla insufficiente adozione delle misure di protezione, di carattere sanitario e organizzativo, alla omessa informazione o formazione. Questo perché la segnalazione costituisce uno specifico obbligo per il lavoratore, come previsto dal decreto legislativo 81/2008. In questo contesto emergenziale non mi pare sia il caso di ipotizzare azioni giudiziarie; è il caso, invece, così come stanno facendo anche alcune associazioni sindacali e alcuni ordini professionali, di denunciare con forza la condizione di rischio operativo a cui è esposto il personale sanitario. La retorica dell’eroe, oltre che fastidiosa, è pericolosa perché fa passare sotto traccia la gravità della situazione. La denuncia, al contrario, è finalizzata a far scattare, con la massima urgenza, interventi correttivi laddove è necessario.
Alessandra Carta
(@alessacart on Twitter)