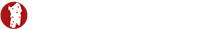Non solo un reportage, ma il racconto di un’epoca e di un territorio martoriato dalla crisi. E’ questo Addio. Il romanzo della fine del lavoro (Chiarelettere), l’ultima fatica dello scrittore marchigiano Angelo Ferracuti. L’abbiamo incontrato.
Partiamo dal titolo: Addio, una forma di saluto struggente, dal sapore definitivo. Che lei rivolge al mondo del lavoro minerario e dell’industria di una delle zone più depresse d’Italia: il Sulcis Iglesiente. Perché questa scelta?
Addio ha molti significati. E’ la fine di un mondo, quello post industriale, è un punto di non ritorno non solo per il Sulcis-Iglesiente, la zona dell’Italia più dimenticata che oggi è anche quella che soffre maggiormente per la mancanza di lavoro, ma per l’Europa che vive una crisi che è quella del capitalismo. A Carbonia, a Iglesias, è evidente la fine di un mondo, di una civiltà del lavoro, se così possiamo chiamarla. Dopo oltre un secolo di sfruttamento, di violenza sull’uomo e sul suolo, restano solo disoccupazione, inquinamento, povertà, una parte del paesaggio sardo martoriato dall’attività estrattiva, deprivato dalle servitù militari. E’ lo stato delle cose del neoliberismo, con un aspetto inquietante, cioè la totale assenza di politica. E poi pensavo alla struggente canzone di Domenico Modugno e all’emigrazione di ritorno, cioè ai giovani del Meridione che hanno ricominciato a partire.
La formula che ha deciso di utilizzare è quella del reportage, che oramai lei usa da tempo per i suoi romanzi, inspirandosi al grande fotografo Mario Dondero, al quale ha dedicato questo libro. C’è una ragione particolare?
Quando sono arrivato la prima volta a Carbonia, da una parte mi ha colpito la particolarità del paesaggio urbano e naturalistico, e dall’altra ho avvertito una sofferenza sociale molto forte. Ho subito sentito un’attrazione per una cittadina fatta solo di classe operaia, e così ho pensato di prendermi cura di questo dolore sotterraneo e ho cominciato a tornarvi molte volte, allargando a tutta la provincia, spinto da una necessità di approfondire da una parte, e di amore per la gente dall’altra. Perché la gente di Carbonia, di Iglesias ha un carattere forte, sanguigno. Il reportage ha una dimensione intanto molto umana, è un lavoro collettivo, comunitario, un po’ come lo interpretavano Kapuscinsky e Mario Dondero, che è stato il mio maestro, ma anche un genere narrativo molto efficace per raccontare questioni complesse. Dentro può finirci il racconto tout court in presa diretta ma anche la storia, i tanti viaggiatori, quella che è stata una violenza.
Entriamo nello specifico. L’obiettivo che si era prefissato era capire cosa succede quando finisce il lavoro. Un momento traumatico nella vita delle persone. Dopo aver parlato, intervistato e documentato le persone che fanno parte del suo libro, ha trovato le risposte?
Non so se il libro ha un valore letterario, questo non sta a me dirlo, però sicuramente ne ha uno storico, documentario, un po’ come le straordinarie foto di Patellani scattate nel Sulcis nel 1950. Volevo fare un libro come quelli dei grandi reporter americani della crisi, raccontare un momento difficile della vita di una comunità, raccontare uno spaccato dal di dentro, vivendolo in presa diretta. Ne viene fuori qualcosa secondo me di molto forte: impoverimento sociale e dignità, voglia di lottare e impotenza, e poi molta solitudine. A parte il sindacato, i preti della Caritas, la solidarietà spontanea, molte delle persone con le quali ho parlato si sentono abbandonate.
Lei afferma che dal racconto emerge quasi una nostalgia per quel passato minerario che è stato lotta alla sopravvivenza, senza dubbio drammatica, ma anche emancipazione politica. Il senso di disorientamento politico e sociale, prima ancora che economico, che avvolge in particolare il territorio del Sulcis potrebbe essere la chiave di lettura per spiegare il tentativo di aggrapparsi a modelli del passato?
Emerge soprattutto la nostalgia, come in tutti i momenti di crisi, il rimpianto per epoche in cui c’era maggiore stabilità sociale.
Nel suo viaggio lei racconta stati d’animo, desideri, sogni mancati di persone che si arrabattano, come in un purgatorio, in attesa di vedere “la luce in fondo al tunnel”, un nuovo inizio, una resurrezione che non necessariamente deve essere legata al modello industriale. Un’attesa che però non si riesce a concretizzare. Quali i motivi, dal suo punto di osservazione?
Secondo me questa era la cosa più difficile da raccontare, cioè queste forme di resistenza anonime, che non fanno coro, l’invisibile che solo la letteratura può raccontare.
Tra miniere e industrie ormai chiuse ha toccato con mano quanto profonda possa essere la crisi. Questo potrebbe spiegare perché centinaia di uomini e donne sono ancora disposti a lavorare in luoghi come questi, che non sono esattamente i giardini dell’Eden?
In questi anni ho raccontato molto la classe operaia. Uno operaio malato di mesotelioma per aver inalato amianto sulle navi al porto di Monfalcone un giorno mi disse “ci si abitua in fretta ai lavori di merda”. Quando non hai altro è così. Ma penso che il rapporto con la miniera non possa essere liquidato allo stesso modo. Nelle miniere del Sulcis c’è stata una civiltà, ed è legittimo restare fedeli alla storia di quell’epica, alle sofferenze, ai morti. C’è una nostalgia per l’essere stati un popolo, una classe. Ma oggi quella classe operaia non esiste più, credo sia lo stato di necessità ,
E poi c’è il ruolo delle multinazionali, sempre alla ricerca del profitto ad ogni costo. Forse lo Stato dovrebbe essere più presente?
Nell’ultimo capitolo del libro, facendo un viaggio in Islanda dove si trova una fonderia dell’Alcoa come quella di Portovesme, non solo cerco di collegare in un comune destino queste due isole meravigliose e selvagge, ma come con l’avvento della globalizzazione dei mercati agiscono le multinazionali. Qui se ne sono andati dopo aver avuto aiuti di Stato per molti anni, inquinando e licenziando. Il mio conterraneo Paolo Volponi le chiamava “le mosche del capitale”, che è anche il titolo di un suo celebre romanzo “Le sapienti colorate voraci mosche del capitale”. Lo Stato ha delegato al mercato, tutto è regolato dal mercato, e il mercato non possiede un’umanità, un’etica.
Il Sulcis Iglesiente tra industrie, veleni, disoccupazione da una parte e la natura di rara bellezza dall’altra, è vittima e artefice del suo destino contradditorio?
Una cosa che emerge dal libro, e che dice anche un militante politico e sindacale piuttosto mitologico come Daverio Giovannetti, è che forse uno sviluppo diverso doveva essere pensato molto prima. Ma credo sia un argomento complesso che ha a che fare con la storia profonda di questa terra, e anche il rapporto ancestrale con il sottosuolo, la fierezza di essere diventati classe operaia, una delle più forti classe operaie del paese. Questo certo non ha favorito il superamento dei distretti minerari. Ma sono argomenti che non attengono al lavoro di uno scrittore, il quale cerca di cogliere la condizione umana.
Carlo Martinelli