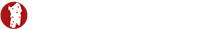Le mani si muovono sull’impasto con movimenti morbidi e precisi. Mamadou è alle prese con una delle pagnotte che sforna quotidianamente nel laboratorio di piazza Galilei a Cagliari, collegato al ristorante in cui lavora come cuoco. Il giovane chef impasta e parla. “Per me è un po’ difficile raccontare”, dice lui con un sorriso dolce e un po’ malinconico. Mamadou Diallo ha 21 anni e viene dalla Guinea. Ha lasciato la sua terra da giovanissimo e ha girato a lungo prima di trasferirsi nell’Isola, dove è arrivato come rifugiato e nel corso di poco tempo è riuscito a costruirsi una vita. Ha conosciuto la paura, la perdita, la solitudine e lo sradicamento ma ha anche avuto la fortuna di incontrare delle persone per bene che lo hanno aiutato a raggiungere i suoi obiettivi. Ora ha un contratto a tempo indeterminato da Cucina.Eat a Cagliari, dove si occupa del pane e lavora ai fornelli insieme ai due colleghi Luca Bertocchi e Federico Peis. Chef e panificatore in erba, calciatore mancato, ma anche ragazzo fortemente attivo nel sociale e nel volontariato: collabora con il 118 e la sua domenica, dopo una lunga settimana di lavoro, è sempre dedicata agli altri. “Quando sei in salute devi ricordare che ci sono anche persone che non stanno bene. Quello che posso dare all’Italia in cambio di quello che ho ricevuto è la mia forza, la mia disponibilità e il mio aiuto”.
Mamadou ha lasciato la Guinea quando aveva 16 anni. Lo zio lo ha fatto fuggire in Gambia per farlo stare in un posto sicuro, lontano dall’epidemia di ebola che stava uccidendo migliaia di persone nel suo paese. “I confini erano chiusi, nessuno poteva entrare o uscire. Sono rimasto lì per un po’ e ho iniziato a studiare inglese, ma era difficile vivere senza i miei genitori”. La sua idea era quella di tornare a casa per stare insieme ai suoi fratellini (“sono piccoli e hanno bisogno di una mano per iniziare a costruire il loro futuro”) e riabbracciare madre e padre, ma lo zio non voleva farlo tornare in Guinea a correre dei rischi. Così lo ha portato in Libia con l’obiettivo di fargli raggiungere l’Italia. “Eravamo 400 persone da dividere in due barche. I libici hanno iniziato a imbarcare prima donne e bambini. Ma anche gli altri volevano salire a bordo per stare vicini ai loro cari. Gli scafisti erano armati di fucile. Era notte e non si vedeva nulla. Sentivo la voce di mio zio nell’oscurità, mi cercava ma non mi vedeva. Poi – dice Mamadou con la voce rotta – ho sentito degli spari. Hanno ucciso diverse persone. Anche mio zio”. Lo sbarco è stato traumatico. Mamadou è arrivato in Italia completamente da solo: aveva sedici anni e si trovava ad affrontare un nuovo paese senza l’aiuto della famiglia, senza conoscenze e senza saper nemmeno parlare la lingua.
“Quando siamo arrivati in Calabria, a Crotone, non volevo scendere dalla barca, perché mio zio non c’era – racconta Mamadou -. Ricordo la sensazione che ho provato dopo tre giorni in acqua. Non riesci a sentirti tranquillo, ti sembra tutto ancora irreale e confuso nonostante l’arrivo nella terraferma”. Il giovane migrante voleva tornare indietro e ha fatto subito la richiesta di essere rimpatriato in Africa. “Mi hanno chiesto il perché e io ho risposto che volevo almeno vedere il corpo di mio zio. Hanno preso tempo per fare in modo che dimenticassi i miei propositi”. Uno degli incontri più importanti in Italia è stato quello con un ex militare che lavorava a Ferrara come mediatore culturale. L’uomo lo ha preso sotto la sua ala protettiva: chiacchierava a lungo con lui e gli dava consigli e indicazioni. “Mi dava un po’ di forza. Mi disse di stare tranquillo e di cercare la mia strada. Mi chiese: cosa vorresti fare? Io volevo giocare a calcio e soprattutto volevo studiare. In Guinea ero nella nazionale under 16. Così mi ha presentato a una squadra locale e ho iniziato ad allenarmi con loro. Non avevo documenti e mi ha fatto prendere dei libri in biblioteca, mi ha comprato dei quaderni. Rimanevo a casa e studiavo la lingua, almeno per poter dire buongiorno, come stai, come ti chiami, quanti anni hai”. Però il tempo passava e nessuno riusciva a garantirgli la possibilità di iscriversi a scuola. Mamadou lo diceva ai suoi interlocutori: non voleva stare in albergo a mangiare e dormire; non voleva soldi ma semplicemente avere l’opportunità di costruirsi un futuro. Dopo una serie di spostamenti – Francia, Svizzera – è tornato in Italia, dove aveva deciso di rimanere. “Quando ero piccolino ero tifoso della nazionale e la prima maglietta che ho avuto era quella di Roberto Baggio”, dice. Così ha fatto richiesta di asilo politico e – dopo una serie di passaggi – deciso di raggiungere la Sardegna.
Una volta arrivato è stato subito trasferito in una casa di accoglienza a Elmas. “Il mio primo giorno lì ho ricevuto il mio primo bacio in Italia – sorride Mamadou -. Mi hanno detto che ero il benvenuto e che mi avrebbero aiutato”. In quel periodo si dedicava principalmente alle faccende domestiche. “La signora della casa di accoglienza ci aveva detto di tenere pulito il luogo come se fosse nostro. In quei giorni non riuscivo ancora a dormire la notte. Andavo a correre alle sei del mattino, tornavo, facevo la doccia e pulivo la casa. Poi preparavo la colazione per tutti. Cucinavo anche a pranzo e a cena”. Il suo rapporto con la cucina nasce da lontano ed è legato al suo rapporto con la madre, un ricordo dolce che spiega anche l’amore che nutre per il suo lavoro. “In Africa cucinano le donne. Mia madre non aveva figlie ed ero io ad aiutarla in cucina. Dopo la scuola le davo una mano, specie quando era stanca. Io in genere avevo molta fame e quindi ho imparato a cucinare in fretta, anche perché poi dovevo uscire subito per andare a giocare a calcio. Ho iniziato così. Il piatto che cucinavo di più è il fouti, riso con verdure e olio di palma. Ma anche un riso con paté di arachidi e carne di manzo. Lo cucino anche qui”.
Intanto gli è arrivato il permesso di soggiorno con protezione umanitaria per due anni. Lo hanno tenuto in casa d’accoglienza per fare un tirocinio come mediatore culturale: il fatto di parlare francese, inglese e arabo e di poter comunicare con gli altri ragazzi era una qualità che tornava molto utile quando ci si trovava ad avere che fare con una ventina di persone che non conoscono l’italiano. I soldi del tirocinio li usava per un corso di cucina online con lo chef Antonino Cannavacciolo. “Spendevo cento euro al mese e mi arrivavano dei libri che cercavo di studiare nel tempo libero”. Poi è stato trasferito in un’altra casa di accoglienza, lo Sprar di Capoterra. Lì lo hanno iscritto alla scuola Azuni e lo hanno portato a fare uno stage da Cucina.Eat, dove ha iniziato a lavorare tutte le mattine, accolto – praticamente adottato – dai titolari Alessandra Meddi e Giuseppe Carrus. “All’inizio non sapevo niente. La cucina italiana è molto diversa da quella africana. Gli chef Francesco Vitale e Mauro Ladu mi hanno insegnato tutto. Erano come dei fratelli maggiori per me. Mi facevano assaggiare i piatti e poi tagliare insalata, pesce e carne. Mi facevano vedere le cose un paio di volte e poi le dovevo rifare. A volte sbagliavo, ma non mi dicevano niente. A me dispiaceva molto invece perché non volevo rovinare il lavoro degli altri. Il rapporto con loro mi ha fatto dimenticare tante cose brutte del passato. Mi hanno dato consigli ed energia. E ho sentito meno la mancanza della mia famiglia grazie alla loro vicinanza. Quando finivo il mio turno non volevo andar via dal ristorante perché volevo rimanere con loro”. Per sei mesi la vita di Mamadou si è divisa tra cucina, scuola, allenamenti di calcio (giocava nel campionato juniores regionale) e poi studio, partita del sabato e volontariato della domenica.
Dopo la fine del tirocinio i titolari del ristorante gli hanno proposto un contratto. C’era un problema però: il permesso umanitario stava per scadere e senza il passaporto potevano dargli solo un permesso per un anno con motivo speciale. “Una volta ottenuto non si poteva più cambiare, o almeno così mi avevano detto. Il padre di Alessandra Meddi è anche andato in ambasciata a Roma per farmi dare il passaporto, ma gli hanno spiegato che dovevo tornare per forza in Guinea. Così ho fatto. Una volta tornato a Cagliari sono andato in Questura e ho fatto la richiesta. Per fortuna è andato tutto bene. Ora ho un contratto a tempo indeterminato, un contratto d’affitto per la casa e sto aspettando un nuovo permesso per motivi di lavoro. Dovrebbero darmelo”.
Oggi Mamadou si divide tra il forno e i fornelli. La mattina si dedica al pane, realizzato con lievito madre. La ricetta è di Francesco Vitale, che ha passato gli ultimi mesi del suo lavoro da Cucina.Eat a insegnare a Mamadou le tecniche di panificazione e tutto quello che sa di impasti, farine e grani. “Mi ha insegnato tutto e mi diceva sempre: vedrai, diventerai più bravo di me. Aveva visto che mi piaceva moltissimo fare il pane”. Poi si trasferisce in cucina, dove lavora con gli altri due giovanissimi chef e contribuisce alla preparazione dei piatti, che cambiano quotidianamente in base alla disponibilità di materie prime acquistate al mercato di San Benedetto. Ora Mamadou è felice e i momenti bui della sua vita sono alle spalle. Ma ha ancora due sogni da realizzare. “Mi piacerebbe formare una famiglia, avere una moglie e dei bambini. E poi riuscire a far venire i miei fratellini qui e aiutarli a costruirsi un futuro migliore”.
Andrea Tramonte